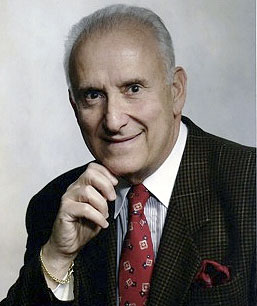Non è una sconfitta. Gli Stati Uniti hanno i mezzi necessari ad isolare politicamente i talebani. La priorità per Washington non è quella di trattare un modus vivendi con i leader talebani, ma di contrastare con tutta la potenza disponibile una resurrezione dell’ISIS. Alla Casa Bianca si mira a concentrarsi sui punti nevralgici del confronto planetario.
Marino de Medici
Come già nel 1975, quando Saigon passò nelle mani dell’esercito nordvietnamita, i catastrofisti americani ed europei sputano fuoco e fiamme per il tragico abbandono dell’Afghanistan. Kabul come Saigon, dunque. Una sconfitta “epica” che cancella ogni credibilità dell’America, proclamano i catastrofisti tra I quali si distingue il Corriere della Sera con uno sfogo occultamente anti-americano.
Gli storici seri sanno invece che il Vietnam non segnò la fine della credibilità degli Stati Uniti e avvertono che il disastro afghano avrà uno svolgimento simile. Vero è che come per l’Afghanistan, molti in America chiedevano a gran voce maggiori stanziamenti per difendere il Vietnam, a cominciare da Henry Kissinger che nel Marzo 1975 dichiarava: “Non possiamo abbandonare gli amici in una parte del mondo senza mettere a repentaglio la sicurezza degi amici dappertutto”.
Ma quanta e quale credibilità persero in realtà gli Stati Uniti? I nemici dell’America gongolavano e Mosca in particolare si apprestava a raccogliere i frutti della ritirata americana dal Sud-est asiatico. Di fatto, però, gli interessi strategici americani non subivano un crollo, mentre era l’Unione Sovietica ad accusare un colpo micidiale, quello della disfatta in Afghanistan nel 1979.
Di fatto, la perdita del Vietnam del Sud non significò la fine della leadership americana né indusse i Paesi in pericolo a ritenere di non potersi più affidare a quella leadership, a tutto scapito del permanere dell’influenza dell’America. Se questa venne in qualche modo compromessa, ciò avvenne in conseguenza del’invasione dell’Irak senza una provata giustificazione strategica. Resta però il fatto che i Paesi alleati ed amici continuarono ad affidarsi alla protezione garantita dall’America e ad offrire supporto reciproco.
Dopo l’abbandono deciso da Biden, gli Stati Uniti non sono privi di risorse per l’Afghanistan, a cominciare dai mezzi necessari ad isolare politicamente i talebani, incluso il diniego di miliardi di dollari del tesoro afghano congelati da Washington. La priorità dell’America non è quella di trattare un modus vivendi con i leader talebani, ma di contrastare con tutta la potenza disponibile una resurrezione dell’ISIS e di altre organizzazioni terroristiche.
Questa strategia si impone non solo per l’Afghanistan ma per tutto il Medio Oriente dove gli Stati Uniti affiancheranno i Paesi minacciati dal terrorismo ISIS. La perdita dell’Afghanistan non cambia questo scenario, senza riguardo alle lugubri profezie dei catastrofisti. L’America recupererà la sua influenza in uno scenario ben più vasto dell’Afghanistan, come già avvenne nel dopo Vietnam degli Anni Settanta.
Occorre ricordare ai catastrofisti che il disastro nel Vietnam aprì un nuovo capitolo nel confronto globale a favore dell’America che acquistò il partenariato di Paesi che temevano l’effetto domino e agivano di conserva con l’America per contenere il comunismo in tre Paesi asiatici: Cambogia, Laos e Vietnam. Ed ancora, gli storici ricordano che l’apertura di Nixon alla Cina ridusse il confronto cino-americano e fece in modo che la vittoria nord-vietnamita non favorisse un predominio regionale cinese.
Paradossalmente, la fine del coinvolgimento americano nel Vietnam obbligò la leadership americana a rivolgere l’attenzione ad altri temi strategici, dall’integrità delle alleanze al negoziato di disarmo con Mosca. Dai difficili frangenti della sconfitta sud-vietnamita finì con l’amergere una più produttiva “soft power” americana. Questa può ora rientrare il gioco con la rinuncia alle guerre senza fine, le “forever wars” che succhiano la capacità dell’America di contribuire al progresso globale.
Come già nel dopo Vietnam, l’America ha la possibilità di plasmare un ordine regionale tra Paesi consociati del Sud-est asiatico che non hanno interesse alcuno a vedere l’Afghanistan nel ruolo di “sponsor” di un nuovo terrorismo. È fortemente improbabile infatti che l’Afghanistan talibano possa trasformarsi in una fiorente democrazia. Tanto vale cogliere la palla al balzo dell’uscita da una guerra interminabile e far leva sugli interessi nazionali delle potenze regionali.
Come avverte lo storico Mark Atwood Lawrence, la sfida insita nello sforzo di Washington di recuperare la sua posizione globale non proviene da leader stranieri improvvisamente turbati da dubbi circa l’affidabilità degli Stati Uniti ma da una problematica interna negli Stati Uniti. Basti pensare all’improntitudine con cui il leader repubblicano al Senato, Mitch McConnell, ha definito il ritiro dall’Afghanistan “una delle peggiori decisioni di politica estera nella storia americana”.
McConnell tenta con ogni mezzo di riconquistare il Senato per i repubblicani nelle prossime elezioni di mid-term. Per lui ed i suoi soci repubblicani, la soluzione era sostanzialmente quella di “kick the can”, ossia di calciare la lattina lungo una strada senza sbocco. La massa degli americani sa invece che Biden ha preso la decisione giusta. Purtroppo la storia è piena di casi in cui i leader pagano il prezzo di decisioni giuste. È del tutto possibile che Joe Biden rientri in questa categoria.
[ L’autore, già corrispondente Ansa da Washington, ha gentilmente autorizzato la pubblicazione di questo articolo, apparso in origine sul suo blog]