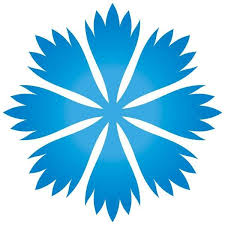Pierluigi Castagnetti ha interrotto un lunghissimo silenzio ed è entrato nel merito della questione che ho posto all’attenzione di tutti gli amici Popolari con la lettera a “Il Domani d’Italia”, e prima ancora con un circostanziato editoriale che non ha suscitato (né avrebbe potuto suscitare) obiezioni nel merito dei fatti riportati.
Lo ringrazio per averlo fatto e anche per la stima che mi esprime dovuta all’apprezzamento per l’attività dell’Associazione piemontese e di “Rinascita popolare”, pur se questo riconoscimento rende ancora meno comprensibile l’“inerzia politica” dell’Associazione nazionale da lui presieduta.
Non ho motivi per dubitare che Castagnetti, come rivendica, abbia sostenuto negli anni una intensa attività di conferenziere esprimendo personali convincimenti in linea con la tradizione e i valori del popolarismo (pur tenendo sempre in ombra l’Associazione, se non qualificandosi come suo presidente nelle recenti celebrazioni del Centenario). E certamente la gestione dell’eredità della DC, insieme alla miriade di altri pretendenti, è stata faticosa e foriera di grane legali. Tutti i proprietari di casa sanno che i beni immobiliari arrecano spese e fastidi, ma di solito comportano anche innegabili benefici, che – lo spero vivamente – non saranno mancati all’Associazione nazionale.
Il suo intervento ha suscitato interessanti risposte nel profondo intervento di Infante sull’attualità di una presenza culturale e politica che si qualifica su concrete proposte politiche, nelle considerazioni di Merlo, sulla necessità di smarcarsi dal PD, e di D’Ubaldo, che richiama l’importanza, oggi, di far sentire unita la voce dei Popolari. Tutti interventi che in qualche modo cercano di guardare avanti, di fare un passo verso una nuova stagione di impegno politico.
Mi pare tuttavia che nel nostro piccolo rischiamo di commettere lo stesso sbaglio che in tanti imputiamo al PD, quello di non voler fare i conti con il recente passato, per chiudere una stagione e poterne aprire una nuova. È però difficile partire con il freno a mano tirato, con silenzi e reticenze che zavorrano il presente.
Ritengo perciò doveroso, e non solo utile, approfondire e chiarire alcuni punti della lettera di Castagnetti, tralasciandone altri pur politicamente importanti (ad esempio, ricordare che nessun popolare sturziano può auspicare un “nuovo partito di cattolici” o “dei cattolici”, avendo nella laicità della politica una stella polare).
Parto da questa sua affermazione: “La mia preoccupazione è sempre stata quella di non promuovere alcuna iniziativa politica e tantomeno alcun tesseramento, sia per onorare il mandato congressuale, sia per non creare situazioni di rimessa in discussione del nuovo soggetto che avrebbero trovato la reazione in primo luogo di parlamentari e dirigenti provenienti dalla nostra storia”. Un concetto che Castagnetti ribadisce più avanti: “La mia preoccupazione è sempre stata quella di evitare di provocare polemiche politiche ‘intestine’, facili da prevedere qualora avessi consentito di non rispettare il mandato congressuale del 2002”. Mandato che prevedeva la confluenza del PPI in un più ampio contenitore politico, il nuovo partito della Margherita, dopo il promettente esordio in coalizione alle Politiche del 2001.
Capisco che nella fase iniziale di questo processo fossero necessarie delle cautele per non far temere un’adesione dimezzata o poco convinta al nuovo soggetto. Ma una volta consolidata la leadership di Rutelli, una volta corroborata dai primi successi elettorali in Europee (2004), Amministrative e Regionali (2005) cosa impediva il decollo di una associazione culturale – ben diversa da un partito – depositaria dei valori del Popolarismo?
L’hanno fatta gli amici piemontesi, che hanno semplicemente attuato quanto previsto dallo statuto nazionale. Già, lo statuto. Non sono ancora così anziano, ma evidentemente ho alcune convinzioni arcaiche: credo nel valore della parola, e della parola scritta; considero la Costituzione il fondamento della comunità nazionale così come, più in piccolo, penso che un sodalizio esiste ed opera sulla base del proprio statuto che ne regola l’attività. Dallo statuto dell’Associazione nazionale “I Popolari” (che qui allego per chi volesse leggerlo) ricavo che lo scopo per cui è stata costituita era “di realizzare attività ed iniziative che mantengano viva ed attuale la tradizione del cattolicesimo democratico e del popolarismo nella vita politica, sociale e culturale italiana, al fine di conservarne la storia e di trasmetterne le esperienze e le idealità alle future generazioni, attraverso la attualizzazione dei suoi contenuti e traducendone i principi in progetto politico, economico, sociale ed istituzionale”. Parole inequivocabili e ancora oggi condivisibili, pensando all’Associazione come “un vero e proprio laboratorio di cultura e di formazione politica, impegnato a ripensare ed attualizzare, nello scenario inedito che a livello interno ed internazionale si va configurando, la tradizione ideale e storica del popolarismo e del cattolicesimo democratico. In questa linea, la sua azione dovrà alimentare idonei percorsi formativi per una nuova classe dirigente e dovrà concorrere all’affermazione di un’etica civile valida per una nuova cittadinanza”.
Se oggi ci lamentiamo, a ragione, dell’irrilevanza del pensiero cattolico democratico nella politica italiana, della mancanza di percorsi formativi della classe dirigente, un po’ di responsabilità va accollata anche a chi non ha dato seguito a questo preciso mandato, che avrebbe affiancato e favorito – non ostacolato – chi perseguiva un più diretto impegno politico.
Anche le omissioni, non solo le cattive azioni, sono da considerare peccato…
E poi – abbiamo il coraggio di dirlo – anche per i cattolici democratici, nella deriva individualista della Seconda Repubblica, sono stati più importanti i destini personali rispetto alle rappresentanze ideali.
Se un peccato originale si può individuare nel costituire l’Associazione nazionale dei Popolari, fu di non affidarla a una personalità fuori dal palcoscenico dei partiti. Castagnetti e molti dei 58 costituenti sono stati parlamentari nella Margherita e poi nel Partito Democratico. Tutti presi dall’attività politica e, anche comprensibilmente, dal proprio posizionamento nei partiti di militanza.
Non è un caso se l’Associazione qui in Piemonte è presente e attiva: Guido Bodrato, dopo aver concluso nel 2004 il suo mandato da europarlamentare, ne è stato l’orgoglioso presidente, impegnato a offrire letture e contenuti che potessero servire anche agli amici impegnati direttamente nell’agone politico – senza fare sconti per ragioni di opportunità o “carità di patria” – e preoccupato anche di farla vivere nel tempo favorendo il ricambio generazionale.
Castagnetti ha ammesso di non aver fatto nulla come Associazione per “non creare situazioni di rimessa in discussione del nuovo soggetto”. Cioè, per dirla con le parole del cartello sui vecchi tram, per “non disturbare il manovratore”. E non importa chi fosse il manovratore: siamo passati da Rutelli a Veltroni a Franceschini a Bersani a Renzi, dal riformismo di centro della Margherita al “partito plurale a vocazione maggioritaria” alla “ditta”, al “partito personale” modellato sul leader. In quindici anni il centrosinistra è stato in continua evoluzione (o, meglio, involuzione). L’unica costante è stata il silenzio dei leader ex Popolari, che si sono fatti andar bene tutto. Anche oggi sembra che ci sia ancora qualcuno preoccupato di non disturbare il nuovo manovratore Zingaretti…
Così l’Associazione nazionale, mai nata per davvero, è caduta nell’oblio, come un vecchio arnese inutile. Anzi, un vecchio arnese che si sarebbe potuto rivelare fastidioso e persino controproducente. Come avrebbero potuto gli eredi di Sturzo e De Gasperi accettare in silenzio l’adesione del proprio partito al Socialismo europeo? Accettarne la trasformazione in un Partito Radicale di massa, che esalta i diritti individuali, tacendo sui doveri, tanto cari ad Aldo Moro, e mortificando i corpi intermedi? Accettarne la deriva metropolitana e centralista, avendo nel proprio DNA le Autonomie locali incentrate sul municipalismo sturziano? Accettarne il leaderismo arrogante e autoritario, così lontano dal rispetto reciproco, dal dialogo costruttivo, dalla ricchezza del pluralismo? Accettarne i nuovi costituzionalisti di riferimento, convinti presidenzialisti, Augusto Barbera e Stefano Ceccanti, in sostituzione dei “gufi” di cultura cattolica Valerio Onida e Ugo De Siervo?
…
La storia è passata e, come l’acqua, non macina più. Ma è anche necessario affrontarla con onestà intellettuale per rimuovere reticenze, incomprensioni e rendite di posizione che sono da ostacolo ad un’azione futura.
Bisognerà trovare una soluzione per l’assurda situazione dell’Associazione nazionale. Possibilmente rilanciandola con le identiche finalità, che rimangono attuali, come ha auspicato Giorgio Merlo. Oppure certificarne il fallimento e liquidarla, così da eliminare un imbarazzante elemento di ambiguità per trovare altre modalità di impegno. Avevo già prospettato “una riunione dei ‘costituenti’, allargata a quanti hanno dimostrato di avere a cuore l’eredità culturale del popolarismo, per valutare il cammino percorso e decidere il da farsi”. Potrebbero farsene promotori “Il Domani d’Italia” con Lucio D’Ubaldo e “Politica Insieme” con Giancarlo Infante, che egregiamente veicolano idee e contenuti programmatici, auspicando come noi di “Rinascita popolare” una nuova stagione dei “liberi e forti”.
Ovviamente coinvolgendo Pierluigi Castagnetti e la struttura dell’Associazione nazionale. Perché anche lui, da persona intelligente qual è, dopo aver rivendicato “la scelta di non promuovere iniziative politiche legate all’attualità”, preoccupato “di evitare e di provocare polemiche politiche ‘intestine’ (…) che avrebbero ulteriormente mortificato la memoria e il prestigio della nostra tradizione”, si sarà chiesto dove ha contribuito a portarci quella scelta. La presenza dei Popolari è oggi visibile, forte? La nostra tradizione è un riferimento nella vita politica italiana? Ne riconosciamo qualche elemento nell’involuzione della nostra democrazia?
Sono domande retoriche, dalla risposta scontata, se tanti parlano di “irrilevanza” della cultura cattolico democratica e tutti concordiamo sul fatto che stiamo vivendo tempi difficili, preoccupanti in prospettiva.
Noi Popolari in questo momento non siamo certamente forti. Non lo siamo anche perché – con pochi fatti, tante reticenze e silenzi – si sono viste scelte di corto respiro, legate a opportunismi e piccole convenienze. Chi aspira all’eredità dei “liberi e forti” dovrebbe volare più alto, sapendo che non si può essere forti se prima non si è liberi.