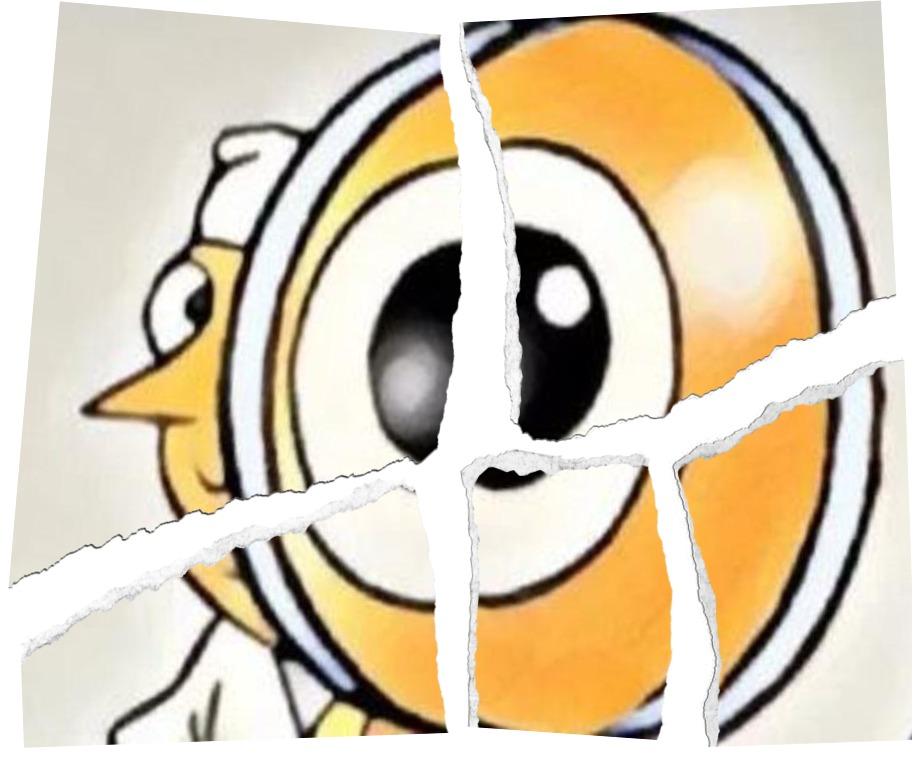Ho sempre pensato che di tutte le possibili forme di violenza quella definita come “simbolica” – di cui dobbiamo il termine al sociologo francese Pierre Bourdieau – sia la più strisciante, infida, pervasiva e nascosta, a volte ammantata da un atteggiamento persino protezionista e addolcito, che la rende ancor più subdola e pericolosa.
Sia cioè il modo per esercitare non tanto un’azione fisica, contro la quale, essendo visibile o prevedibile, si riesce talvolta ad adottare reazioni e contromisure, in poche parole a difendersi, quanto un’influenza apparentemente eterea e impalpabile sulla mente e sui comportamenti delle persone, scontata e subìta con disattenzione o sottostima ma capace di esercitare un dominio semplicemente gestendo in conto terzi un consenso inconsapevole, stabilendo sudditanze e gerarchie di pensiero.
Semplifico subito il concetto e spiego perché sono giunto a questa conclusione.
Come al solito nel ragionamento mi ha aiutato la politica e si tratta di una conclusione che non mi sembra cervellotica ma alla portata di tutti.
Ogni parentesi elettorale, si sa, è un teatrino di mirabolanti invenzioni: promesse, miracoli, scenari onirici, visioni, incantesimi.
Ma è la parentesi più vistosa e invadente di una messinscena che dura tutto l’anno, con la complicità di una televisione ormai gestita dai partiti e magistralmente affinata nella capacità sopraffina di portare i cervelli all’ammasso.
Fin qui nulla di nuovo sotto il sole.
Ma sono i siparietti dei soliti noti che suscitano irritazione.
Quando la politica era una cosa sporca e cattiva i dibattiti congressuali stabilivano la linea da seguire, giusta o sbagliata che fosse: c’era un leader, c’erano le correnti, i colpi bassi e le bucce di banana per far scivolare rovinosamente amici e avversari, c’era il manualetto per attribuire incarichi e prebende interne.
Ma i simboli dei partiti, quelli che l’elettore vedeva nella stucchevole “tribuna politica”e ritrovava poi nelle schede nel segreto dell’urna, rappresentavano le idee: la croce, la falce e il martello, il sole nascente, la fiamma tricolore, la bandiera italiana, l’edera. Erano una cosa pulita, l’iconografia di un’idea, di un valore, ispiravano adesione e senso di appartenenza.
Poi ci sono stati altri alberi, fiori, vele e varie allegorie: ma sempre nei limiti del misurato pudore.
Ecco dunque il problema che pongo: da un po’ di tempo in qua, diciamo da alcuni anni, in quei simboli si sono insinuati dei nomi, come se rappresentassero un valore aggiunto per esprimere meglio la sintesi del pensiero, l’efficacia dell’immagine.
Ma quei nomi non sono solo il rafforzamento di un’idea, sono la rappresentazione simbolica di una volontà neanche tanto occulta di possesso: siano essi il cognome del capo o il logo da lui scelto.
Spiegano, a chi non l’avesse ancora capito, che mentre si predicano trasparenza e democrazia, mettere il proprio nome o un logo, qualche parola nella cornice di un partito significa sancire, legittimare, la regola di un possesso. Il partito è questo, io il suo capo, ergo il partito sono io.
Dietro quei nomi ci sono gerarchie di potere che sottendono gerarchie di pensiero: chi aderisce e vota sa chi comanda, sotto quel simbolo ci sta una ben rigida struttura piramidale di potere e di fedeltà. La gente non dice più voto per il tal partito o per l’altro ma “voto per tizio, caio, sempronio”. Con quali conseguenze pratiche è facile immaginare.
Mi pare si tratti di una concezione feudale e possessiva, personale, persino individualizzata della politica: il partito è “lui”, se ti va è così, altrimenti puoi sempre cambiare padrone.
Trovo aberrante che uno possa anche solo immaginare di essere così in gamba, così moralmente integro, così esemplare da far coincidere la ricchezza e la pluralità delle idee di un movimento politico con l’immagine della propria persona e del proprio nome, da essere addirittura sintesi fondativa del partito stesso.
Una presunzione francamente insostenibile che vale per scissioni, nuovi partiti personali e conversioni, da destra a sinistra, passando per il centro. Senza far nomi.